PRESENTAZIONE LIBRO
Firenze, Leone Piccioni: lezioni su Montale
di Tiziana Santoro
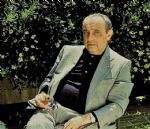 A
Firenze, nella suggestiva cornice della Sala Ferri, sita in Palazzo Strozzi,
Mario Biondi, Giuseppe Conti, Giuseppe Grattacaso e Silvia Zoppi Garampi hanno
presentato il libro “Com’è tutta la vita e il suo travaglio. Lezioni su Ossi di
Seppia di Eugenio Montale”. Il volume comprende 100 lezioni svolte da Leone
Piccioni (nella foto), noto critico letterario e vicepresidente Rai, su Montale e rivolte
agli studenti dell’Università IULM di Milano. L’autore, esperto critico di
Ungaretti, non ha rinunciato a raccontare Montale ai suoi studenti, fermamente
convinto che in poesia non ci siano schieramenti, bensì che tutta la poesia
possa e debba trovare spazio nel cuore e nella vita degli uomini. Svincolato da
ogni schieramento culturale e polemica, Piccioni ha agito da critico libero da
pregiudizi e intellettualismi e ha spiegato gli Ossi di Montale verso per
verso, attraverso una prosa attenta agli aspetti universali, poi simbolici e
lessicali, sempre mettendone a fuoco la “bellezza letteraria”.
Della
parola e della rima, Piccioni ha colto soprattutto l’effetto musicale, il suono
e il ritmo che descrivevano le variazioni di un paesaggio, il quale non si
discostava mai dallo stato d’animo del poeta. In “Ossi di Seppia” – sosteneva
il critico – Montale offriva la “lettura
dentro se stesso e in rapporto col
paesaggio”. La lirica di Montale, pur nascendo da una dimensione interiore,
diveniva universale perché relativa al significato spirituale e ideale dello
stato d’animo assunto dall’uomo nel mondo. Piccioni, allievo di De Roberto e
Ungaretti, esperto conoscitore di 40 anni di critica letteraria e dell’approccio
critico di Contini, riprendeva il concetto crociano di “poesia”-“non poesia” e
lo approfondiva, a suo modo. Dopo aver analizzato il fenomeno del “montalismo”
e osteggiato lo schematismo di certi critici, Piccioni puntava l’attenzione sul
messaggio genuino e letterale della poesia, perché la più grande lezione di
Montale è circoscritta a quella capacità di “vincere la noia, sapendo attendere i trasalimenti dell’anima”.
Il
critico Piccioni si rivolgeva agli studenti dell’Università IULM e non perdeva
mai di vista le peculiarità dei suoi interlocutori: quegli studenti erano
giovani aspiranti a leggere e a comprendere una poesia ostica. Questo ha
determinato la scelta di un metodo d’insegnamento che si rispecchiava
fedelmente nella personalità di Piccioni: letterato e al tempo stesso
comunicatore. Il critico, fermamente convinto che maestro e discepolo dovessero
condividere un codice, rifiutava l’approccio tecnico, esclusivo ed escludente
di Contini, prediligeva la lettura e il commento all’analisi puntigliosa del
testo e cercava nella letteratura “la
verità di incontri della cattedra e della vita”. Fermamente convinto che la
grande poesia non avrebbe mai potuto escludere nessuno, compieva in aula una
vera e propria “mediazione ecclesiastica”
per avvicinare a Montale i suoi studenti. Rinunciava a farsi portavoce di una
letteratura secondaria, per concentrarsi solo su quella primaria.
Il
critico era attento a mettere a fuoco la poetica della negazione che
accompagnava ogni affermazione del poeta e attraverso cui egli restituiva l’esperienza
della grande guerra sotto forma di memoria acustica e visiva. Affidando l’esperienza
della guerra all’oblio, Montale, rifiutava la retorica poetica dei suoi tempi.
Allo stesso modo, Piccioni, lontano da presupposti retorici, comunicatore e
inventore di situazioni e incontri, parlava a un pubblico vasto. Nelle sue
pagine, utilizzava frequentemente il termine “umanità”, convinto che la poesia
dovesse e potesse parlare a tutti. Piccioni incarnava il modello del “critico-facilitatore”,
“viveva la letteratura da dentro”, il suo punto d’osservazione non era mai
esterno e lontano. Il critico guardava sempre dall’interno. La più grande
lezione che il docente ha fornito agli studenti dell’Università IULM è che “la letteratura si può raccontare e che il
commento è l’idea di raccontare la letteratura”.
Quando
si rivolgeva ai giovani, Piccioni non usava citazioni che avrebbero potuto
creare barriere e allontanarlo dagli studenti, egli metteva a fuoco il
destinatario e rimuoveva tutto ciò che poteva essere d’ostacolo alla
comunicazione. L’approccio rivoluzionario del critico e ancor più del docente
era nella consapevolezza che “la parola
non doveva escludere, ma offrire la strada per un’interpretazione, dando all’allievo l’idea che non esisteva mai una
sola interpretazione”. Comunicatore e divulgatore del sapere, ma pur sempre
uomo di raffinata cultura, Piccioni non rinunciava a interrogarsi sull’utilità
della poesia, pertanto, è approdato a una concezione ideale e spirituale del
messaggio poetico. Piccioni sosteneva che la poesia non fosse utile, ma che
nell’inutilità completa, risiedesse il massimo dell’utilità morale. Con questa
definizione, il critico toccava il culmine dell’universalismo, ribadiva quel
suo intimo affetto e quella sua spiccata attenzione per l’umanità.
Al
termine dell’incontro, è stata trasmessa l’intervista esclusiva di Piccioni a
Montale, incontro concesso dal poeta esclusivamente per stima e amicizia verso
il critico. Quest’ultima è un frammento indispensabile per ricordare al
pubblico che i poeti sono vivi, sono uomini d’intelletto, ma anche dotati d’ironia
e sensibilità personale. Piccioni, intervistatore, ha restituito l’immagine di
un poeta-uomo che non si prendeva troppo sul serio, che canzonava il suo
talento multiforme con naturalezza, assecondando la casualità della vita.
Sorprende di Montale, questo suo essere sempre dentro se stesso e la scrittura,
infatti, anche quando la moglie combatteva per la vita in ospedale, Montale
rimaneva saldo e ripiegato in sé, dentro quella vita intesa come esperienza
intima, travaglio dell’animo, che trovava espressione concreta nella sua arte.
Montale, durante l’intervista, riconosceva come legittima la propria libertà di
scrittura ed anche quella d’interpretazione del lettore.
Poco
importa, dunque, se egli abbia scritto di Papa Anacleto, come qualcuno crede,
piuttosto che di un caricatore di fucili, perché l’esercizio critico dell’interpretazione
è una libertà fondamentale che l’uomo non può non esercitare. Piccioni,
tuttavia, quando voleva trasmettere l’immagine più intima di Montale,
rinunciava alla affascinazione delle immagini, si affidava al racconto. Quello
di un pomeriggio milanese, in cui interloquiva col poeta della sua poesia
preferita “Spesso il male di vivere ho incontrato”. A questo punto,
il critico si abbandonava al ricordo di un Montale canuto e stanco, sprofondato
nella sua poltrona, con cui recitava sentitamente quei versi. Al termine del
coro, Piccioni notò che Montale piangeva. La poetica aveva rivelato, ancora una
volta, la sua universalità: l’empatia profonda tra due uomini del mondo che nel
mondo sentono insieme.
|
