STORIA
San Panteno, l’ape sicula
di Nicola Antonazzo
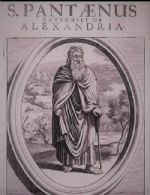 Panteno,
Santo per la Chiesa Cattolica, per anni maestro della Scuola di Alessandria,
testimone della necessità di trasmettere e “tradurre” la bellezza del Vangelo
ai neofiti e ai lontani. Un ponte tra le culture: prima di tutto tra la
tradizione cristiana occidentale e quella orientale; in seconda battuta tra
quelle presenti all’interno del bacino del Mediterraneo. Soprannominato Ape
Sicula (Clemente Alessandrino, Stromata, I,1,11; Eusebio, Historia
Ecclesiastica, V,11,2.). Panteno fu “uomo assai famoso per la sua cultura”,
modello ideale per coloro che abitano il sapere come luogo di incontro e non
come occupazione di un titolo. Modello perché seppe associare la predicazione
alla formazione, concependole come due diverse forme di evangelizzazione.
Ricostruire
la sua vita non è impresa facile. Poche, frammentate e incerte sono le notizie
che sono giunte fino a noi. Le fonti alle quali ci riferiamo per tracciare
questo breve profilo si rifanno essenzialmente alla Historia Ecclesiastica di
Eusebio e alle testimonianze di Clemente Alessandrino, Origene e Massimo il
Confessore. Il primo fu suo successore alla guida della scuola egiziana.
Nessuna intenzione di far dire ai testi ciò che non dicono, ma un semplice
tentativo di sintesi per definire i tratti di una figura poco conosciuta.La
ricostruzione della vita e del pensiero dell’ape passano dalla comprensione del
contesto teologico in cui agì maggiormente, la Scuola di Alessandria. Porto
strategico del mediterraneo, accesso quasi esclusivo al mondo egiziano, l’immagine
che ci è stata trasmessa dalla storia è quella di una Città intellettualmente
vivace fin dalla sua fondazione, avvenuta quattro secoli prima di Cristo per
opera di Alessandro Magno. Culla dell’ellenismo, in essa si posero le basi per
l’incontro tra le culture greca e giudaica. Incontro che ebbe nell’opera dei
Settanta uno dei suoi esempi più conosciuti. In quest’ambiente così ricco e
operoso dal punto di vista della cura dell’analisi metafisica dei dati della
fede fiorisce la prima grande scuola di scienza sacra del cristianesimo, il
didaskaleion.
Stando
alle notizie in nostro possesso, la ricostruzione della vita di Panteno ruota
intorno a tre questioni, utili per ricavarne dati biografici essenziali e fondamentali
al fine di ricostruirne uno breve profilo teologico: origine siciliama,
provenienza da ambienti fiolosofici stoici, viaggio missionario in oriente,
animazione della Scuola di Alessandria. Legate all’ultima questione risultano
problematiche la sua produzione letteraria e l’influsso che ebbe nei confronti
di alcuni discepoli eccellenti che lo chiamano direttamente in causa a sostegno
della loro formazione.La
sua origine siciliana deriva da una definizione del suo discepolo Clemente che
in Stromati, I, 1, 2 lo definisce “ape sicula”. Tale definizione è incastonata
nel brano in cui Clemente parla dei presbiteri, “uomini beati”, cui sembra
andare alla ricerca per ascoltare parole “piene di vita”. Tale ricerca, stando
sempre ai primi passi di Stromati, termina, con la scoperta in Egitto, del più
illustre. La metafora utilizzata dal Clemente per descrivere i tratti del suo
maestro nascono da un accostamento che a prima vista potrebbe sembrare forzato.
Il tipico volo delle api che attingono fiori della prateria, in questo caso i
testi Sacri sintetizzati nell’espressione “profeti” e “apostoli”, è immagine
dell’interprete delle scritture. Poesia e gnosi sono qui sintetizzati dall’icona
“ape”, raffigurazione tipica del poeta. Si tratta di un passaggio omesso
altrove ma che rimane l’unico aggancio tra la figura di Panteno e la sua terra
d’origine.
Ancor
meno precisa e decisamente fumosa è la sua data di nascita collocata intorno al
140 d. C. Eusebio, senza darci una data certa, ce ne parla nel libro V della
Historia dedicandogli l’intero capitolo 10, subito dopo la collocazione storica
al tempo dell’imperatore Commodo oggetto di un breve capitolo introduttivo, il
nono, che ci offre le coordinate spazio temporali: Alessandria d’Egitto al
tempo del Vescovo Giuliano. Sappiamo che Commodo governò dal 180, pur
condividendo le responsabilità imperiale già dal 177.Da
Eusebio, apprendiamo ancora il suo iniziale indirizzo filosofico, lo stoicismo,
dal quale si distaccò per aderire al cristianesimo. Ignoriamo le dinamiche che
portarono a questa conversione, così come ignoriamo i contorni della dottrina
filosofica alla quale sembra aver aderito Panteno. Durante il secondo secolo,
infatti, la definizione di stoicismo sembra essere legata più sincretismo in
cui intervengono anche platonismo e aristotelismo, piuttosto che uno stoicismo
puro. Terzo fondamentale capitolo introdotto dalla presentazione di Eusebio è
la principale occupazione di Panteno: la direzione della scuola di dottrina
sacra presente ad Alessandria. Sulla dottrina e sul ruolo svolto da questo
Centro durante il secondo secolo dell’era cristiana parleremo più avanti. Prima
è necessario far luce sulla pagina più difficile della via dell’Ape Sicula. Infatti,
Eusebio, prima di introdurci sul ruolo che ebbe all’interno del centro
egiziano, ci informa che Panteno iniziò la sua attività presso la «scuola» dopo
una lunga parentesi dedicata a numerose iniziative.
Dall’abbandono
dello stoicismo e con l’adesione al cristianesimo, si apre, infatti, sulla vita
di Panteno, una lunga parentesi che lo vede araldo del Vangelo di Cristo alle
nazioni orientali, fino a un non meglio precisato paese degli indiani. La
collocazione di questa comunità non è del tutto chiara. C’è chi parla di
Arabia, ma non è detto che debba essere esclusa a priori la possibilità che
abbia viaggiato fino al confine con le Indie. La plausibilità del viaggio,
considerate le rotte commerciali che collegavano l’Egitto all’India
meridionale, non fa da paio con la descrizione dell’opera che Panteno si trovò
a svolgere presso quello popolazioni, se non altro per la considerazione di
Eusebio circa la presenza di cristiani evangelizzati dall’apostolo Bartolomeo.
A questo, si aggiunge, cosa ancora meno probabile della prima, il possesso da
parte di questa comunità di un Vangelo di Matteo in caratteri ebraici.Insomma,
pur prendendo buona la possibilità che Panteno abbia realmente operato in
regioni così lontane, è difficile sostenere l’ipotesi di una
pre-evangelizzazione di origine apostolica. Ciò è più facilmente spiegabile
attingendo alla letteratura apocrifa cristiana che tendeva a pseudografare
imprese missionarie di discepoli etichettandole con il nome di un apostolo ben
più conosciuto e importante. Tale diffusione missionaria fu reale e lo si può
attestare piuttosto per l’apostolo Tommaso, ma le altre considerazione vanno
accolte con beneficio d’inventario. Pur nella modesta quantità di riferimenti
storici, possiamo affermare che San Panteno fu un testimone della nuova cultura
cristiana che da lì a pochi secoli avrebbe abbracciato l’intera Europa
meridionale e l’Africa settentrionale.
|
