RECENSIONE
Il peso della farfalla: una piccola grande storia
di Tiziana Santoro
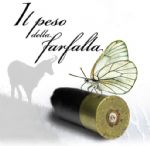 “Il peso della
farfalla”, una storia semplice scritta da Erri De Luca. L’autore è un
conoscitore della montagna e racconta le imprese di un camoscio che duella con
un bracconiere. La grandezza dell’autore sta nell’aver condensato, in appena 60
pagine, spunti che si prestano a riflessioni più profonde, che superano il
limite del raccontare, per lasciare spazio alla riflessione. Gli input muovono
in più direzioni, dentro l’opera di De Luca si trovano il sentimento della
solitudine, la tensione umana verso le sfide e, al tempo stesso, quegli argini
quali la vecchiaia, il declino, l’incomunicabilità, lo scorrere del tempo,
l’idea di Dio, che contraddistinguono l’esperienza del vivere umano. “Il peso
della farfalla” è prima di tutto la storia di un’ammirazione profonda di un
vecchio bracconiere per “il re dei camosci” che, nell’ultima stagione della sua
vita, primeggia e guida il suo branco, muovendosi con disinvoltura ed abilità
tra le rocce impervie.
Come una corona sul suo corno scintilla una farfalla,
tratto distintivo di un essere che domina il suo regno con naturalezza estrema,
sublime esempio di una perfezione che è tensione irraggiungibile. Il vecchio
bracconiere, cresciuto senza freno e senza regole, è orfano del suo branco, non
sa trasmettere le sue esperienze, non comunica, sceglie la via della solitudine
perché più forte, è la propensione istintiva verso l’impresa da compiere.
Nell’ultima stagione della sua esistenza, al bracconiere la vita appare come
“una figura perfetta” in cui “non c’è quadratura”. Per la prima volta, guarda
le nuvole oltre se stesso e osserva lo scorrere del tempo, “un vento che
scavalca” e che prova a riacciuffare con grande sforzo e fatica. Nasce la
consapevolezza che la vita non appartiene agli uomini, ma che è, in qualche
misura, roba che va restituita al flusso vitale dell’universo, dopo averla
usata. Rimane al bracconiere la consapevolezza di essere “ciò che ha commesso”,
poiché “un uomo che dimentica è un bicchiere messo alla rovescia, un vuoto
chiuso”. La vita di un uomo e tutte le stagioni andavano col mondo, questa era
la scoperta dell’età adulta. C’è spazio per un pizzico di rimpianto nelle
riflessioni del bracconiere, quello per il tempo presente di cui non ha saputo
godere pienamente, perché l’uomo, per sua stessa natura, “rimastica le
informazioni dei sensi, le combina in probabilità.
L’uomo, così, è capace di
premeditare il tempo, di progettarlo. È pure la sua dannazione, perché dà
certezza di morire”. La superiorità del camoscio è anche in questo, nella sua
destrezza di vivere sempre nel tempo presente, l’unica conoscenza che serve.
Scrive De Luca: “In natura non esiste la tristezza (…). Le bestie stanno nel
presente come vino in bottiglia, pronto ad uscire. Le bestie sanno il tempo in
tempo, quando serve saperlo. Pensarci prima è rovina degli uomini e non prepara
alla prontezza”. Consolazione per l’uomo nel suo momento di declino è “il
padrone di tutto”, allusione del bracconiere all’esistenza di Dio.
Un’esistenza, quella di Dio, reputata impossibile da un uomo che da solo aveva
scoperto il bene e il male e che in assenza di un “capomastro” autonomamente
“prosperava” senza rivolgere preghiere, senza cercare alcun ascolto; eppure nel
buio della notte, il bracconiere guardava il cielo e porgeva il suo
ringraziamento a Dio, perché credere nell’impossibile era, anche per lui,
consolazione e compagnia. Non manca una riflessione sui rapporti umani, sulla
natura finita di quegli uomini che “hanno inventato i minuziosi codici, ma
appena c’è occasione si azzannano senza legge”.
A quelli che sono per il
bracconiere “tempi senza giustizia”, fanno da contrasto le leggi senza tempo
della natura e del branco che, nell’istante in cui il camoscio si accascia a
terra sfinito dagli spari del cacciatore, non fugge al frastuono per salvaguardare
se stesso, ma si avvicina per porgere l’ultimo saluto e omaggio al valore del
suo re. Nel racconto, può sembrare insolita la figura di una giornalista, una
donna che “ha la faccia di una scarpa di cuoio che ha camminato a lungo e che
si è adattata al piede come al guanto”, eppure spezza la tesi/antitesi tra
regno animale e umano e si colloca come una figura aliena sopra le parti. Alla
giornalista interessa la comunicazione, il dialogo, il racconto. Subito le
parole pronunciate dal bracconiere l’apostrofano, collocandola quasi fuori
dalla trama stessa, su un piano che non è tra quelli messi a confronto. Un
pretesto – quello usato da De Luca – per accennare alla più estrema e difficile
forma di comunicazione, quella tra uomo e donna, non senza una certa presa di
coscienza: “Le donne hanno superiore volontà.
Un uomo non arriva a volere
quanto una donna, si distrae, s’interrompe, una donna no. Una donna è quel filo
di ragno steso in un paesaggio che si attacca ai panni e si fa portare. Gli
aveva messo addosso i suoi pensieri e non se li scrollava. Un uomo che non
frequenta donne è un uomo senza”. Non manca d’infinita naturalezza, né di un
certo lirismo, De Luca quando scrive: “Le donne fanno mosse di conchiglia, che
si apre sia per buttar fuori che per risucchiare all’interno”. S’intuisce la
condizione di affascinazione che subisce il bracconiere/uomo e il pudore
accennato da chi ammette la propria vulnerabilità: “Ci sono carezze che
aggiunte sopra un carico lo fanno vacillare”. Nel racconto di un duello “tra re camoscio” e
“re bracconiere” – che altro non è, se non pretesto per guardare nel cuore
dell’uomo – non poteva mancare il finale perfetto. Il bracconiere uccide il
camoscio e s’inchina alla sua superiorità, non caccerà più, trasporterà la sua
carcassa in spalla, per dargli degna sepoltura. In quell’istante, anch’egli si
piega alla morte e al suo destino. Lì troverà dopo il disgelo un boscaiolo,
fusi in un’unica materia, inseparabili in un’unica essenza: l’uomo e quel
camoscio che era stato per lui fonte d’ammirazione, ispirazione profonda e
costante tensione verso un ideale di perfezione irraggiungibile.
|
